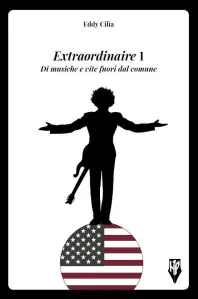“Ehi, ehi, ehi, dimmi Wilson Pickett,/ehi, ehi, ehi, dimmi tu James Brown,/questa voce dove la trovate?/Signor King, signor Charles, signor Brown,/io faccio tutto per poter cantar come voi/ma non c’è niente da fare, non ci riuscirò mai./Penso che sia soltanto per il mio color che non va./Ecco perché io vorrei,/vorrei la pelle nera,/vorrei la pelle nera.” (Nino Ferrer, Vorrei la pelle nera, 1967)
Come già raccontavo nella prefazione a Venerato Maestro Oppure, il volume con il quale nella primavera 2020 ha preso le mosse un progetto di parziale antologizzazione degli immensi archivi accumulati dacché nell’83 decisi di provare a vivere scrivendo di musica (a ventun anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell’età), cominciai a comprare dischi quindicenne. Era il 1977. Era il tempo del punk e della disco. Nel primo inciampai casualmente quasi subito e fu amore a primo accordo: di White Riot. La seconda era ovunque: impossibile scansarla, un dovere per un rocker per di più simpatizzante per il PCI (era pure un tempo di tribù che non si parlavano, quando non si combattevano) schifarla, o quantomeno dare a intendere di farlo. Con formidabile equivoco quella che nella terra di origine era fra il tanto resto la colonna sonora della comunità gay qui da noi fu adottata dai giovani di destra, che ne colsero solo l’aspetto edonista, laddove a sinistra veniva squalificata come degenerazione commerciale di una gloriosa tradizione che affondava le radici nel blues e aveva avuto come sviluppo ultimo il free jazz. Che poi nel segreto delle proprie camerette Archie Shepp (se c’era) restasse intonso e un giro a certi singoli passati da insospettabili amici (nel mio caso un allievo del conservatorio che in quella stessa prestigiosa istituzione finirà per insegnare violino) lo si facesse invece fare (ricordo ancora con imbarazzo il giorno in cui mia madre mi sorprese ad agitarmi inconsultamente sulle note di Daddy Cool delle Boney M ─ o era qualcosa dei Village People? ─ e sorrise indulgente) restava, per l’appunto, un segreto. D’altronde: negli Stati Uniti di certi dischi certi rocker (che però detestavano pure il punk) organizzavano roghi. Il reggae invece, in quanto forma di espressione indiscutibilmente ribelle nonché colonna sonora per le prime canne, era ok, anche se oltre a Bob Marley e Peter Tosh non si andava. Anche se naturalmente il primo reggae lo ascoltai dai Clash: Police And Thieves (la versione originale di Junior Murvin mi entrerà in casa un dodici o tredici anni dopo). E sempre a Strummer, Jones, Simonon e Headon fui, come tanti, debitore della prima disco music che era legittimo farsi piacere, perché erano loro: The Magnificent Seven. Inaugurava nel dicembre 1980 il triplo “Sandinista!” e nell’aprile dell’anno dopo usciva pure a 45 giri, precedendo di sette mesi This Is Radio Clash. Che è la ragione, quest’ultima, per la quale posso serenamente rivendicare che mentre della disco illo tempore capii poco, per non dir nulla, con l’hip hop fui viceversa profondamente sintonizzato sin dai suoi primordi. Ma converrà che faccia ora un piccolo, piccolissimo passo indietro.
L’inizio della mia grande storia d’amore con una black declinata in praticamente ogni sua accezione, ma per cominciare con il soul e l’errebì dell’era aurea, data proprio 1980. All’epoca possedevo forse un centinaio di LP (collezione che mi sembrava sterminata) e fra essi appena un minimo sindacale di blues (Muddy Waters e Willie Dixon, cui ero arrivato per tramite dei Rolling Stones; Bo Diddley, comprato perché era andato in tour come spalla indovinate di chi) e una raccolta di Otis Redding. Cui se ne aggiungeva allora una seconda, “Gonh Be Funky” di Lee Dorsey, acquistata senza avere la minima idea di chi fosse costui soltanto perché a firmare le note letteralmente autografe sul retro di copertina era Joe Strummer, ed era un mondo che mi si spalancava davanti. Ma a cambiarmi per sempre la vita era un film, non una canzone o un album: The Blues Brothers. James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, John Lee Hooker (e Cab Calloway, Steve Cropper, Chaka Khan…) li ho conosciuti grazie a John Landis. Per un bel po’ (un bel po’ misurato con il metro di un non ancora ventenne) per me Sweet Home Chicago resterà legata all’interpretazione di John Belushi. Il che renderà incredibilmente emozionante sentirla infine da Robert Johnson. Nel frattempo mi ero messo a studiare. Non ho mai smesso. Non smetterò mai. Sarà che ho scritto tanto, per un sacco di anni e una quantità di testate, dalle più autorevoli alle più improbabili, di musiche afroamericane; sarà che nel 2003 Riccardo Bertoncelli mi affidava la redazione, per la collana Atlanti musicali della Giunti, del tomo dedicato a Soul e rhythm’n’blues – I classici, che mi risulta sia stato uno dei più venduti della serie (il che rende un mistero che un seguito dedicato ai moderni non mi sia mai stato commissionato, nonostante avessi dato la mia disponibilità): fatto è che godo di una fama, che so essere immeritata, di superesperto in materia. In realtà conosco un tot di persone (non necessariamente colleghi; anzi: di colleghi pochini) che ne sanno parecchio più di me. In realtà non passa mese in cui non faccia una piccola o anche clamorosa scoperta, o non mi renda conto che un pregiudizio era in parte o completamente ingiustificato. Il rovescio della medaglia, quello bello, è che sapendo di non sapere continuo a scavare e rinvenire tesori. Magari un giorno a dio (che se esiste è per forza di colore) piacendo metterò in cantiere un altro libro per riferirvi di cosa ho imparato negli ultimi dieci-quindici anni o su di lì.
Per intanto ripropongo. Il volume che avete fra le mani nasce come ristampa, integrata con alcuni articoli che all’epoca per ragioni che mi risultano oggi oscure non inclusi e pochi altri di successiva redazione, di uno che vedeva la luce nel 2007 per i tipi di Tuttle Edizioni e prendeva il titolo, Scritti nell’anima, da una rubrica dedicata a blues e soul, funky ed errebì di cui fui titolare, per un totale di cinquantasei puntate pubblicate fra il settembre 2000 e il dicembre 2005, per il mensile “Blow Up”. Già allora non mi limitavo a una semplice raccolta in ordine di uscita. Rimescolando il tutto provavo, aggiungendo all’uopo pezzi apparsi precedentemente sempre sul giornale in questione e una manciata di altri usciti sul bimestrale “Bassa Fedeltà”, sull’allora settimanale “Il Mucchio” e sul trimestrale “Extra”, a disegnare una scaletta in grado di tracciare (per quanto naturalmente con enormi lacune: una pur tascabile enciclopedia l’avevo in ogni caso già firmata) una mappatura della black music da Robert Johnson a Prince per tramite del racconto delle vicende biografiche e artistiche di alcune decine dei suoi protagonisti. Scritti nell’anima è esaurito dal 2010 (il suo autore da molto prima) e da allora non si contano quanti mi hanno chiesto se mi crescesse una copia da vendergli (no, ne ho giusto una) o se sarebbe mai stato ripubblicato. Eccolo qui.

Però a un certo punto ho capito e di conseguenza deciso che a rimetterlo fuori limitandomi a ingrassarlo con una dozzina di articoli avrei fatto sì cosa gradita a chi voleva leggerlo, ed era arrivato in ritardo, ma che nel contempo avrei perso per sempre l’occasione di trasformarlo in un qualcosa di decisamente altro e più significativo. Peggio: ne avrei tradito lo spirito. Avrei implicitamente dato ragione a quelli che nel 1977 non intesero ─ e io, incolto sciocco, con loro ─ come la disco, lungi dall’essere uno svilimento di quanto l’aveva preceduta nell’ambito delle musiche di ascendenze afroamericane, si ponesse rispetto a esse come uno sviluppo in perfetta continuità. Nel solco ─ into the groove ─ di una tradizione che parte dagli schiavi che cantavano e percuotevano i loro tamburi a Congo Square, nella New Orleans degli anni ’50 del XIX secolo. In maniera non dissimile da quei Last Poets che in un parco della Big Apple il 19 maggio di un 1968 fatidico pure a ragione di ciò ponevano le basi, proiettando nel XX secolo la figura del griot africano da cui discendevano in linea diretta, di ciò che da allora si chiama rap e da lì a qualche anno, e sempre nei parchi newyorkesi, si sarebbe evoluto in hip hop.
Va da sé che se alla stragrande maggioranza dei solisti e dei gruppi affrontati in Scritti nell’anima sono arrivato quando erano ormai da decenni storia, e spesso leggenda, di una parte importante dell’epopea dell’hip hop ho invece avuto la fortuna di essere, sebbene giocoforza da lontano, testimone in presa diretta. Ebbi l’occasione preziosa di occuparmene da cronista piuttosto che da studioso. Assai meno di quanto mi sarebbe piaciuto ma abbastanza da potere allestire, con una scelta di pezzi diversi dei quali d’epoca, quella che è ben più che una mera appendice al libro del 2007. In Super Bad! il filo rosso, o se preferite nero, che lega dalla prima all’ultima le vicende che vi sono narrate ─ dal 1927, quando Blind Willie McTell incideva le sue prime quattro facciate, al 2003, anno in cui gli OutKast pubblicavano il monumentale “Speakerboxxx/The Love Below” ─ è ben visibile a chi non sia cieco più di colui che (ipse dixit Bob Dylan) cantò il blues come nessuno mai.
Più che un filo, sono trame su trame. Robert Johnson che dà appuntamento a un crocicchio al demone della mitologia vudù Papa Legba per vendergli l’anima in cambio di una prodigiosa abilità chitarristica e autoriale sa cosa sta facendo esattamente quanto Flavor Flav che, da lì a mezzo secolo, assumerà sul palco l’iconografia e le mosse di Ghede, in quel medesimo pantheon guardiano delle ossa dei defunti e governatore di sesso, morte e bambini. Billie Holiday apre inconsapevolmente la stagione delle lotte per i diritti civili con Strange Fruit e l’America la ripagherà vessandola (ci provava pure con Ray Charles) come farà con James Brown, colpevole più di avere alzato la testa che di averla persa. Jerry Butler entra in politica, Ice-T e Tupac Shakur (da rubricarsi alla voce “curiosità”: identiche le ambientazioni ultraterrene di un video di costui e della canzone con cui senza saperlo Johnnie Taylor si congedava) vagheggeranno di farlo. E a proposito di quest’ultimo: come somiglierà tragicamente la sua uscita di scena a quelle altrettanto premature di Sam Cooke, Malcolm X, Dyke Christian; se vogliamo, di Marvin Gaye. Se di “It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back” dei Public Enemy Chuck D dirà che “volevo fosse il ‘What’s Going On’ di questa generazione”, stessa impresa felicemente arrischiata dal Gil Scott-Heron di “Reflections”, la copertina di “Stankonia” degli OutKast citerà quella di “There’s A Riot Goin’ On” di Sly & The Family Stone. Di Atlanta gli OutKast, proprio come quegli Arrested Development che di Sly e sodali si erano presi carico di una parte dell’eredità. “Qualcuno mi dice cosa posso e non posso fare, qualcosa mi frena./È perché sono nero?” cantava Syl Johnson in Is It Because I’m Black? e in “The W” i Wu-Tang Clan lo campioneranno, laddove nel suo ultimo album il menzionato poco più su, e loro antesignano in quanto pioniere del rap, Gil Scott-Heron coverizzerà Robert Johnson provvedendo così a chiudere un cerchio. L’ennesimo. Cosa accomuna, ad esempio, sempre Gil Scott-Heron, Charley Patton, Lead Belly, R.L. Burnside, Ted Hawkins, Billie Holiday, Ray Charles, Little Willie John, James Brown, Miles Davis, Ol’ Dirty Bastard, Coolio, il solito Tupac? Facile: l’essere stati tutti ospiti, chi per qualche giorno e chi per anni, delle patrie galere. Potrei andare avanti per pagine e pagine. Rilevando, per dire, che la pratica delle scherzose gare di vanterie che i bianchi scoprivano con Bo Diddley fu fra gli elementi fondanti del rap. Che quella della jam riguarda il jazz come l’hip hop. Eccetera.
Ma di pagine da leggere ne avete già quattro abbondanti centinaia. Doveste mai annoiarvi, sarà solamente colpa mia. Non certo delle cento storie che ho provato a raccontare.
Torino, 8 dicembre 2021
Tratto da Super Bad! – Storie di soul, blues, jazz e hip hop.