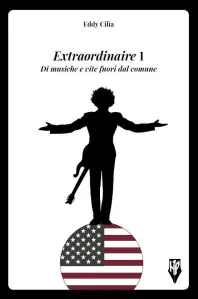Chissà se l’idea di chiamare “Quiet Is The New Loud” un secondo album che era quasi come fosse il primo (incredibilmente, il vero esordio non è nemmeno citato nella scheda che Wikipedia dedica al duo) venne a Erlend Øye o a Eirik Glambek Bøe. In scaletta un brano omonimo non c’è e i ragazzi (venticinque anni entrambi all’epoca) non ritennero di rimediare a posteriori. Chissà se avrebbero se no attirato l’attenzione della stampa inglese, fomentandone a tal punto l’entusiasmo che provò a inventarsi una scena che non c’era (frugo nella memoria e negli archivi e di gruppi degni di nota ne trovo tre: Turin Brakes e Stairsailor, che debuttavano in lungo quello stesso anno, e It’s Jo And Danny, che provarono a mettersi in scia quando erano stati in realtà i primi ad affacciarsi alla ribalta). È che un titolo così geniale avrebbe potuto inventarlo giusto un giornalista del “New Musical Express” con un futuro da pubblicitario di grido. È che dopo gli anni del grunge e del Britpop, dell’alt-rock e del post-rock, una musica principalmente di chitarre acustiche e armonie vocali pareva perfetta per un secolo che si affacciava alla storia potendo ancora (per pochissimo: fino all’11 settembre) fantasticare di essere altra cosa, e migliore, rispetto al precedente. “Il silenzio è il nuovo rumore”, si potrebbe provare a rendere, ma non rende. Sia come sia: tutti pazzi per i Kings Of Convenience nella primavera del 2001 e a riascoltarla oltre vent’anni dopo quella dozzina di canzoni fa ancora una formidabile figura. Di “nuovo” non regalava in realtà e naturalmente nulla, come chiunque minimamente avvertito e con magari in casa i dischi dei Belle And Sebastian oltre a quelli di Simon & Garfunkel e Nick Drake già allora sapeva, ma che scrittura! Che è quello che conta nel pop. Quello, e il sentimento.
Mica facile arrivare a conquistare le classifiche ─ in verità più nel resto d’Europa che le britanniche, anche se buttale via sessantamila copie ─ partendo da Bergen, che dopo Oslo è la seconda città della Norvegia ma vi sfido a puntare un indice verso una carta geografica e dire “è lì”. Lì dove copie ne bastano venticinquemila per appendere in casa un disco d’oro ed è difficile ai limiti dell’impossibile, proprio per le dimensioni ridotte del mercato (metà degli abitanti della Lombardia e un costo della vita proporzionato a una ricchezza che sconfina nell’opulenza), fare dell’essere musicisti più di un hobby. A meno, appunto, di partire. Erlend ed Eirik mandavano in avanscoperta prima dei demo, quindi tre singoli “made in Norway” e credevano di avere trovato l’America dove l’America è quando nel 2000 la Kindercore (di Athens, Georgia; vi diranno qualcosa nomi come Pylon e B-52’s, R.E.M. e Of Montreal) si offriva di pubblicare un CD di fatto antologico visto che quasi tutti i brani che raduna erano già apparsi sul trio di 7” di cui sopra. Copertina di rara bruttezza, “Kings Of Convenience” non merita l’elevato esborso (mentre scrivo c’è chi su Discogs prova a venderlo a quei duecento euro) necessario oggi per procurarselo. Le canzoni ci sono già, ben sei su dieci verranno ripresentate (e fa metà esatta del programma) in “Quiet Is The New Loud”, la magia ancora no. Quella che nella nuova versione di Winning A Battle, Losing The War si accende davvero, dopo che le chitarre da felpate si sono fatte guizzanti, quando a un minuto o poco più dalla fine entra la batteria. Che nella successiva, festosa a dispetto del titolo Toxic Girl è presente sin dalle prime battute. La batteria. Quella che fece tutta la differenza di questo mondo quando Tom Wilson decise nel 1965, senza manco avvisare gli interpreti, di aggiungerla a The Sound Of Silence e un brano passato del tutto inosservato l’anno prima rendeva Simon & Garfunkel (sempre i più citati quando si scrive dei Kings Of Convenience) delle superstar a loro insaputa, dalla sera alla mattina. Ciò che nel… come dire?… primo debutto era appena un bocciolo in questo secondo fiorisce grazie a poche quanto sapienti aggiunte: lì uno sbuffo di tromba, là un fremito di violoncello, un piano a ricamare, una batteria discreta ma decisa, una chitarra che abbandona il folk per avventurarsi nel jazz o azzardarsi brazileira. Come, l’ultima che ho detto, nella squisita Singing Softly To Me, in Leaning Against The Wall, in una The Girl From Back Then che è John Martyn alle prese con Antônio Carlos Jobim. Laddove Failure è un Nick Drake euforico come mai fu e Parallel Lines un Paul Simon al contrario più desolato che semplicemente malinconico. Non è saudade qui, piuttosto spleen, capite a me.
La notte è più buia subito prima dell’alba e nel 2001 nessuno avrebbe potuto garantire che per il vinile il sole sarebbe sorto ancora. Di “Quiet Is The New Loud” stamparono pochissime copie ed è a ragione di ciò che oggi per una in condizioni accettabili il prezzo si aggira sui settanta euro e una intonsa può arrivare a costare più del doppio. Risulta allora particolarmente gradita (ma il lettore interessato si affretti, per certo non ne hanno tirate di più) una riedizione arrivata nei negozi sotto Natale, griffata sempre Source, distribuita dalla Universal e con un prezzo di listino di eurelli 28. Tale e quale a “Riot On An Empty Street”, che in origine vedeva la luce nel 2004 e del predecessore forniva replica fors’anche più ispirata, tanto che in molti ritengono (sono d’accordo) sia questo e non quell’altro il capolavoro della coppia. Si presenta con una luminosissima (di nuovo: il titolo depista) Homesick che non potrebbe essere più Simon & Garfunkel nemmeno se fosse di Simon & Garfunkel, si congeda con una meditabonda The Build-Up che il featuring di Leslie Feist fa un po’ Suzanne Vega, in mezzo dispensa meraviglie come la pianistica e incalzante Misread, il valzer Stay Out Of Trouble, una Sorry Or Please dove Nick Drake incontra Paul Simon e una Live Long che in mano ad Al Stewart nell’Anno del Gatto avrebbe spopolato. Sistemata fra una I’d Rather Dance With You invero ballabile e una Surprise Ice rarefatta e quasi luttuosa. Nota di colore: più che in qualunque altro paese era da noi che l’album faceva strage di cuori, scalando le classifiche fino alla terza posizione. Quanto è vero che “amor ch’a nullo amato amar perdona”: dal 2012 Erlend Øye vive in Italia, a Siracusa.
Pubblicato per la prima volta su “Audio Review”, n.439, febbraio 2022.