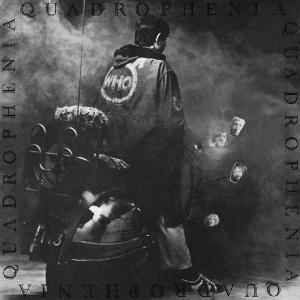Cosmos
Dopo il diluvio di uscite della prima metà degli anni ’90 culminato nel 1996 con il doppio “The Singles”, il programma di riedizione dell’opera di Sun Ra ha rallentato molto il passo. Non si sa se rallegrarsene (si rischiava di dovere accendere dei mutui) o inquietarsi, perché tanto manca ancora all’appello e nel frattempo pure quelle ristampe cominciano a latitare. Direi però la seconda che ho detto, vista ad esempio la qualità di quello che dovrebbe essere un disco “minore” (e in termini assoluti lo è anche) ma che nondimeno riserva pagine di notevole seduzione.
Fra gli articoli più rari (non contando i live distribuiti ai concerti) del catalogo del Nostro, “Cosmos” vedeva la luce nel 1976, con una bella copertina adeguatamente fantascientifica e con l’unico difetto di evocare i lavori di Roger Dean per gli Yes. Se la grafica poteva ingannare l’ignaro acquirente dell’epoca, certamente la musica gli si rivelò, in tutti i sensi, di un altro pianeta. È uno degli album più “psichedelici” di Sun Ra, che suona il rocksichord (!?) e oltre a comporre (si suppone, la confezione non riporta i crediti) dirige un’orchestrina di undici elementi. Si parte e si arriva con le relativamente convenzionali (fiati evocativi e un certo sapore di swing) The Mystery Of Two e Jazz From An Unknown Planet, ma in mezzo ci sono delle gran belle stranezze. Come l’indianeggiante Interstellar Low-Ways o la big band marziana (saturnina, anzi) che si dà al free di Néo Project #2. O la quieta, ma davvero lunare come da titolo, Moonship Journey. Un viaggio affascinante. Con Sun Ra non si rimpiange mai il prezzo del biglietto.
Pubblicato per la prima volta su “Blow Up”, n.17, ottobre 1999.
Lanquidity
“Ci sono altri mondi (dei quali non vi hanno detto nulla)” titola, tradotto, il quinto e ultimo dei brani in scaletta in questo disco del 1978, riportato nei negozi in autunno dalla benemerita Evidence. O forse sarebbe il caso di dire “portato” e basta, siccome la stampa originale circolò soltanto laddove l’uomo di Saturno e i suoi discepoli facevano base, ovvero Philadelphia, e nelle città dove suonarono nei mesi immediatamente successivi. Con “Lanquidity” sono ventisei gli album di Sun Ra riediti dalla Evidence (e all’elenco vanno aggiunti un CD doppio e uno singolo antologici, altra cornucopia di leccornie assortite) nell’arco di un decennio durante il quale sono stati ristampati pure i titoli su ESP e hanno visto la luce un’infinità di live. Probabilmente, mai in vita Herman Poole Blount aveva visto tante sue opere in circolazione contemporaneamente. I mondi che l’industria, e più in generale l’establishment jazz, avevano passato sotto silenzio sono ora a portata di mano di chiunque desideri esplorarli. Non è indispensabile una preparazione specifica. Solo orecchie disposte all’avventura.
Uscito in piena era disco, “Lanquidity” sciorina funk sopraffino azzardandosi persino a dispiegare, in Where Pathways Meet, chitarre acide come non mai (tanto per ribadire l’affinità spirituale con le ciurme capitanate da George Clinton). Frequenta pure il rhythm’n’blues (si ascolti come spingono i fiati in That’s How I Feel) e, in ritardo sull’exotica, anticipa la fascinazione dell’Occidente per la world music. È sexy e spirituale insieme. È un’ennesima conferma della genialità di un uomo che tanti, troppi, trattarono da ciarlatano.
Pubblicato per la prima volta su “Audio Review”, n.210, febbraio 2001.
Some Blues But Not The Kind Thats Blue
Della sterminata discografia di Sun Ra più del numero delle opere colpisce, non appena si comincia a grattarne la superficie, lo spaziare senza posa: fra swing e avanguardia, doo wop e funky, exotica e bebop, free e psichedelia, cameristica ed errebì e quant’altro. E più ancora della monumentalità del lascito e dell’eclettismo a lasciare stupefatti è la qualità media, con capolavori a bizzeffe e il resto come minimo intrigante. Estesissimo il programma di ristampe seguito alla dipartita dal pianeta, nel 1993, del Nostro e per quanto mi riguarda lo benedico e lo maledico: ho decine (molte decine) di suoi album e che me ne manchino probabilmente altrettante quando qualcuno tira fuori da forzieri in apparenza inesauribili gemme dello splendore di Some Blues But Not The Kind Thats Blue mi lascia insieme esilarato e frustrato. E non scambiatemi per un collezionista del cazzo. È roba indispensabile. È roba che dopo la tua vita è più bella.
È questo un Sun Ra raro non solo nel senso che, dopo una tiratura in qualche centinaio di copie nel 1978 per l’etichetta dell’artista stesso, in trent’anni non era mai stato ristampato. È raro perché, contemporaneamente, lo vede alla testa di un gruppo tascabile rispetto alla consueta Arkestra e alle prese con un repertorio in massima parte di standard. Rispettati ma trasfigurati ed ecco una I’ll Get By che gronda sorrisi e swing, ecco una soffusa quanto spigolosa My Favorite Things da confrontare con le “anta” coltraniane, ecco una malinconica e fragrante d’Oriente Nature Boy, ecco una Black Magic spumeggiante di percussioni e post-New Thing senza eccessi. Sun Ra è una droga.
Pubblicato per la prima volta su “Il Mucchio”, n.644, marzo 2008.
Meets Salah Ragab In Egypt
Lamentavo un paio di numeri fa che il programma di ristampe dell’immensa discografia di Sun Ra, fittissimo nell’ultimo lustro, cominciasse a segnare il passo, con molto ancora mancante all’appello. C’è veramente da augurarsi che riprenda vigore, visto lo straordinario valore di quanto, ormai con il contagocce, seguita a rivedere la luce. Questo “Meets Salah Ragab In Egypt” ad esempio, riedizione con due brani in più (per un totale di oltre mezz’ora di musica finora del tutto inedita) di un album poco conosciuto che a metà anni ’80 dava testimonianza dell’incontro fra l’Uomo di Saturno e Salah Ragab, il maggiore dell’esercito egiziano fondatore della prima orchestra jazz di quel paese (tutta composta di militari!). Un alieno anch’egli, evidentemente.
Nonché un compositore di prima categoria, tant’è che Sun Ra, in una serie di collaborazioni iniziata nel ’71 e prolungatasi fino al 1984 sceglieva, evento raro, di suonare in prevalenza materiale composto da un altro. Risultato? Settanta minuti, in questo CD dalla bella confezione cartonata, di jazz dagli accenti exotici dominato da tripudi di percussioni e scorribande fiatistiche di gusto manciniano. Godibile già al primo ascolto e generoso di rivelazioni (quando mai Sun Ra non lo è?) nei successivi.
Pubblicato per la prima volta su “Blow Up”, n.19, dicembre 1999.
Mayan Temples
Nell’estate del 1990, nell’ambito di un tour europeo, la variopinta carovana della Sun Ra Arkestra faceva tappa in Italia. Giovanni Bonandrini, patron della Black Saint, ne approfittava per fotografarne il momento presso i Mondial Sound di Milano, fra il 24 e il 25 di luglio. Risultato, questo “Mayan Temples”. Decisione invero tempestiva, quasi avesse letto in una sfera di cristallo, quella del Bonandrini. Qualche mese dopo l’uomo di Saturno finiva su una carrozzella per via di un ictus dalle cui conseguenze non si sarebbe mai ripreso del tutto. Ci avrebbe lasciati il 30 maggio 1993.
Prima premessa: sebbene non sia in assoluto uno dei suoi capolavori, “Mayan Temples” è comunque opera significativa perché riassuntiva come poche altre della poetica di Sun Ra. Dunque ideale per il neofita. Seconda: è ad ogni modo, con “Somewhere Else”, quanto di meglio abbia prodotto nel suo ultimo quindicennio di permanenza sul pianeta Terra. Venghino allora, siore e siori. Si accomodino al grande e magico spettacolo della Arkestra. Potranno ascoltarla passare senza soluzione di continuità da swinganti impasti da big band ellingtoniana a ballate intrise di romanticismo, da bene organizzate risse fra tamburi e ottoni a sornione fughe nell’exotica, da safari africani a siparietti da music hall, declinando nel contempo (sempre meravigliosa la voce di June Tyson) soul e ciò che non si può definire altrimenti che psichedelia. Da Cab Calloway a George Clinton e ritorno. Splendido irregolare, Sun Ra. Sebbene fervano i preparativi di canonizzazione, l’impressione è che ci vorrà ancora molto tempo prima che la straordinarietà del suo apporto alla storia del jazz sia compresa appieno.
Pubblicato per la prima volta su “Audio Review”, n.213, maggio 2001.